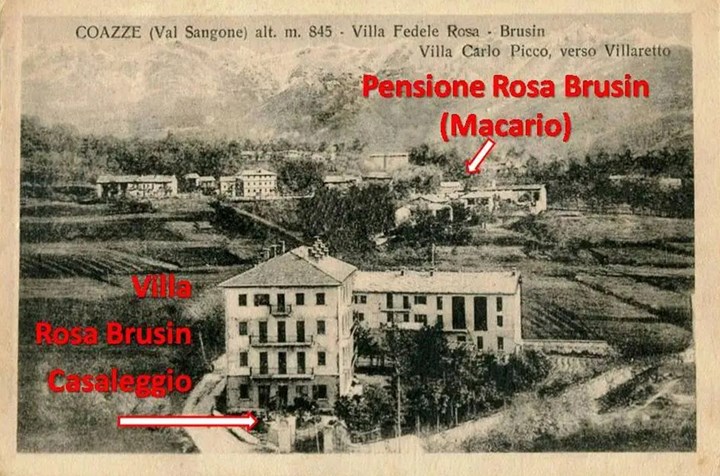Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo
Prima del boom economico e della diffusione di massa di motociclette e automobili, gli spostamenti avvenivano a piedi e la gente era sparsa nelle borgate vicine ai terreni che coltivava e su cui pascolava il bestiame.
Gli acquisti importanti si facevano alle fiere o al mercato, molte riparazioni e manutenzioni si facevano in autonomia, ma alcuni servizi venivano portati a domicilio dai venditori ambulanti.
Ma venditori è un termine improprio, in una società misera che risparmiava su tutto e acquistava solo l’indispensabile, oltre ai venditori, che spesso avevano il loro negozio in una carretta o in una gerla, fornivano servizi molto utili i riparatori e i manutentori, che stagnavano pentole, aggiustavano ombrelli, arrotavano lame. Ma nelle borgate salivano anche i compratori, di bestiame, di capelli e, più recentemente, di frutta e funghi.
LO STAGNINO
Gli ambulanti passavano di casa in casa, fin nelle borgate sperdute a offrire le loro merci, i loro servizi, con tanto di pubblicità gridata in un misto di dialetto e di lingua italiana.
Uno stagnino strillava le sue abilità press’a poco così:
Dòne,dòne,spùse e madòne (Donne, donne, spose e suocere)
l’è rivà ‘l magníń (è arrivato lo stagnino)
a fè növ casaròle e peiröl (a far nuovi casseruole e paioli).
Curàge, dòne, purtéli fòra (Coraggio donne, portateli fuori).
Ucasiùń ünica, travài d’artìsta! (Occasione unica, lavoro da artista!)
E se una donna gli risponde:
Oh, vost travài a cùsta trop! (Oh, il vostro lavoro costa troppo!)
E me om a vől pa!” (E mio marito non vuole!)
Il “magnìń” non si lascia scoraggiare:
E vui, madàma, diséie gnènte. Sté ciütu (E voi, signora, non ditegli niente. State zitta)
Rabastè i quatt solt, fe rangé le ròbe (Tirate fuori i quattro soldi, e fate aggiustare le cose)
Na volta rangià, a suń rangià (Una volta aggiustate, sono aggiustate)
Da tempo i “magníń” sono disoccupati, le pentole di acciaio inossidabile non si bucano più.
Nel dialetto coazzese sono rimaste alcune espressioni: “Nèir cùme ‘n magnìń!”, “ Anmagninèse” “Anmagninè” (Nero come uno stagnino, sporcarsi, sporcare di fuliggine).
Molti “magnìń” venivano dalla valle Orco, tanto da essere chiamata “la val di magnìń”. Dalla valle di Piantonetto, sopra Locana, arrivava quello che a Coazze è stato uno stagnino mitico, Giovanni Osella, non a caso soprannominato “magnìń”. Quando il mestiere è tramontato si è convertito all’allevamento delle trote in una vasca presso il cimitero di Forno, dove ora è sepolto.

Uno stagnino all’opera.
L'ombrellaio e i venditori di scope
Un altro richiamo dal sentiero:
Oh, béle fùmne, béle fìe (Oh, belle donne, belle ragazze)
gnün parapiőva da rangè? (nessun ombrello da riparare?)
Mi i ràngiu tüti, t’co i pi rut stort e malandà (Li aggiusto tutti anche i più rotti storti e malandati)
Era l’ombrellaio, “parapiuvé”, un altro dei mestieri estinti, che ci farebbe comodo anche oggi!
I venditori e le venditrici di scope potevano annunciarsi così:
Ramasse, ramasse bumpàte (Scope, scope a buon prezzo!).
Arrotini e stracciai

Un arrotino all’opera a Giaveno davanti alla Chiesa dei Batù. Foto scattata da Franco Gregorio negli Anni Ottanta e tratta dal libro Giaveno e i suoi protagonisti, Aghepos, 2006.
L’arrotino non passava nelle borgate alte, prive di strade, perché doveva spingere la bici o il carrettino che portava la mola, da cui deriva il suo nome in dialetto: “mulìtta”. Nelle fiere e nei mercati non mancava mai. Il suo “spot” era all’incirca questo:
Mulìtta, mulittaaa! Tisòire e cutél (Arrotino, arrotinooo! Forbici e coltelli)
madàme e mariòire, munsù galantòm, se a tàiu papì, purtémle a mi (signore, signorine, signori per bene, se non tagliano più, portateli a me)
A taiaràń cume ‘l fö. Tisòire e cutél. Mulìttaaa! (Taglieranno come il fuoco. Forbici e coltelli. Mulittaaa!)
I raccoglitori di stracci urlavano:
Strassé, stracciaio (Stracciaio, stracciaio)
Strass ‘d làńa, pel ‘d lapìń, (Stracci di lana, pelli di coniglio)
Fer e rümènta. Mi pàgu biń, mi i pàgu sübit! (Ferro e cose vecchie. Io le pago bene, le pago subito!)
Strassè, strass bianch e culuràaa! (Stracciaio, stracci bianchi e colorati)
Ogni tanto passava la merciaia o il merciaio (“lu marséi”, “la marsìri”). Portavano a tracolla una povera cassetta, ma l’invito ai clienti era solenne:
Fassuléti, bei fassuléti! (Fazzoletti, bei fazzoletti)
Da nas, da col, da tésta, ‘d tüti i dì e da fèsta (Da naso, da collo, da testa, di tutti i giorni e da festa)
Gnènte, ma gnènte car! (Niente, ma niente cari!)
Güce, gücìń, strìnghe e bindéi, fil, pussuàr e butùń (Aghi, spille, stringhe e nastri, filo, automatici e bottoni)
Gnènte, ma gnènte car! (Niente, ma niente cari!)
Le massaie si impietosivano per il loro gran camminare sui sentieri, li facevano sedere sotto un albero o nella stalla (secondo le stagioni) e comperavano una spoletta di filo o una bustina di aghi, anche se non ne avevano bisogno. A una ambulante e ai suoi discendenti rimase lo stranome “Fasuleti”.
La gente di montagna aveva buoni rapporti con gli ambulanti, specialmente con i “magnìń” che si fermavano più a lungo nelle loro case per il loro lavoro e a cui si dava ospitalità finché avevano finito. Allora erano battute, risate, barzellette, notizie dal mondo, commedie per il prezzo: ognuno recitava convinto la sua parte con la speranza di risparmiare o guadagnare un centesimo…
Dove arrivava la strada sterrata o una mulattiera un po’ larga e non troppo ripida, si inerpicava un altro genere di ambulante, il venditore di generi alimentari: caffè e surrogati di caffè come il famoso “olandese”, pasta, tubetti di conserva di pomodoro e anche frutta e verdura “ ‘d davál” che non cresceva alle borgate alte (pesche e uva).
Di solito questi frutti erano riservati ai malati o agli operai delle fabbriche che li mangiavano come pietanza con il pane. E così facevano i bambini che avevano l’acquolina in bocca solo a sentirne il profumo.
Il venditore, che arrivava su con un carretto a mano o tirato da un asinello (più tardi, dopo la guerra, con la motocarrozzetta), gridava di borgata in borgata il nome e la qualifica: “lu frütasé”!
È rimasto nella memoria degli anziani il grido di un ambulante di Giaveno: “lu Büdíń’”. Le donne scendevano a comperare, risparmiando chilometri di strada e alleggerendo il carico da portare a casa dal mercato.
Talvolta i borghigiani vendevano agli ambulanti mirtilli e funghi anche se per questi ultimi passava, nelle stagioni giuste, “lu bulaiùr” e c’era l’alternativa del mercato di Giaveno e la vendita diretta ai ristoranti e alle osterie.
In collaborazione con Guido Ostorero, Laboratorio Alte Valli propone alcuni estratti di La Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco, importante testimonianza sulla vita e sul lavoro delle nostre montagne: li trovate RAGGRUPPATI IN QUESTO LINK.
Per saperne di più vi rimandiamo al sito ScuolaGuido, su cui potete leggere l'articolo completo: Mestieri (ambulanti) che la bisnonna ricorda: “magnìń, mulìtta, buciné…